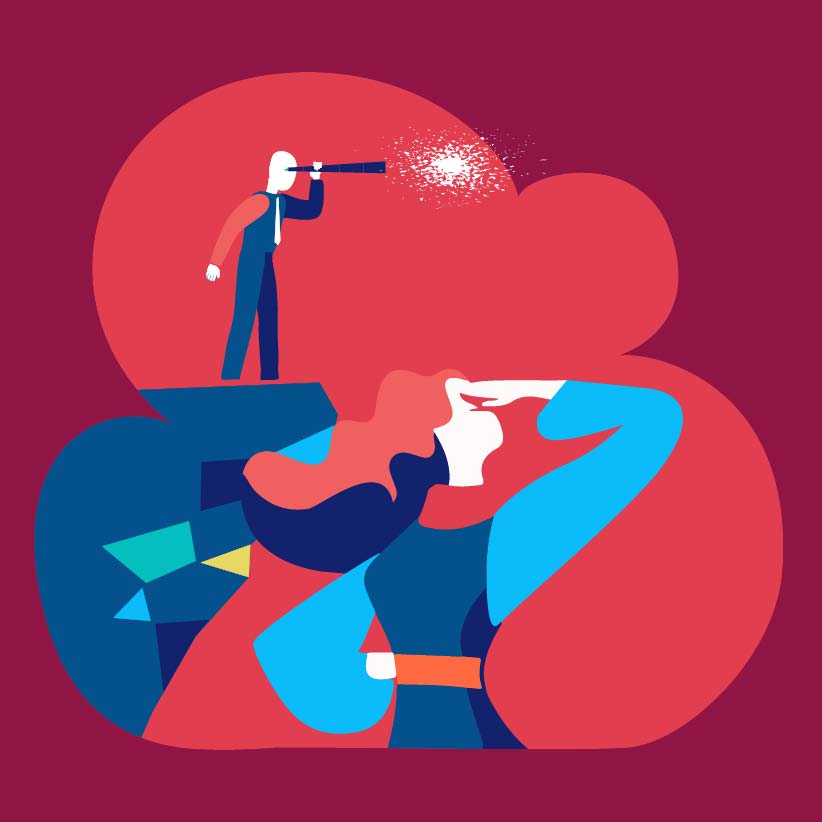Le “ricette” per lo sviluppo di un marchio
Alcuni commenti, a partire dalle opinioni sul mio articolo “Tutti i marchi devono essere...”

Selezione dell'Editore
Il mio precedente articolo “Tutti i marchi devono essere...”, è stato uno degli articoli che ha ricevuto più pareri (e risposte). Evidentemente la retorica del paradosso e dellʼironia è efficace, perché mette il dito sulla ferita e motiva le reazioni. Visto il successo, la userò più spesso. Ma questa tecnica ha anche i suoi svantaggi: non tutti catturano i doppi sensi e, a volte, le battute devono essere spiegate. Una cosa è parodiare il pensiero semplicistico e lʼaltro è essere semplici: alcuni mi hanno preso per “elementare”. Fortunatamente, la maggior parte dei recensori sembra aver colto il significato della mia ironia.
In risposta a tali opinioni e, soprattutto, a coloro che hanno espresso riserve o dubbi, ho trovato utile per tutti, me compreso, dilungarmi nei chiarimenti. In quellʼarticolo penso di aver reso molto chiaramente che il problema non è nella norma ma nella sua pretesa di universalità; pretesa manifestata nella parola “tutti”. In altre parole, ho affermato che questi standard non sono falsi, poiché in alcuni casi sono criteri validi e devono essere applicati. Questo aspetto sembra non essere stato percepito da alcuni dei lettori.
Nel vasto universo dei marchi aziendali (e, inutile dirlo, nel caso dei marchi grafici in generale) è assolutamente impossibile (oltre assurdo) cercare una regola generale. Anche la presunta universalità della necessità del marchio grafico non è valida: ci sono entità che non ce lʼhanno, non ne hanno bisogno e sarebbe grave se lo inventassero.
Ad ogni modo, dovrebbe essere chiarito che la messa in discussione di tali regole divenute un dogma non dovrebbe portare allʼidea, ugualmente errata, che lo sviluppo di un marchio grafico sia privo di vincoli e che il progettista possa fare ciò che gli viene in mente.
La convinzione che non ci sia uno standard di applicazione universale nella progettazione dei marchi non dovrebbe essere associata a una rivendicazione di indeterminazione o “libertà creativa”. Tale convinzione nasce dallʼanalisi del campo esaustivo dei brand, cioè dei marchi di tutti quei settori che li utilizzano.
Anche scartando i brand di prodotti e servizi e limitandoci ai marchi aziendali e istituzionali, questo universo ha unʼimmensa eterogeneità e di conseguenza richiede marchi molto diversi tra di loro: sono diverse le esigenze specifiche di ogni settore e, persino, di ciascuna entità individuale.
Per fare un chiaro esempio: un paese chiamato Repubblica Dominicana non può avere un brand dello stesso tipo di quello di Cuba. Entrambi hanno bisogno di un marchio-paese. I loro profili e condizioni di comunicazione sono molto simili; ma uno ha un nome di diciannove lettere e lʼaltro di quattro. Nel primo, la necessità di un simbolo è indiscutibile, mentre il secondo potrebbe essere sufficiente, se appropriato, lʼuso del solo logo con uno sfondo.
Normalmente, la tendenza a rivendicare un qualche requisito universale, ad esempio la sintesi, deriva dal fatto che il campo considerato è stato limitato a determinati settori, dove tale requisito è pertinente. Cioè, lʼanalisi sul campo non è stata completa.
Se lʼanalisi includesse, ad esempio, il settore della moda, il requisito di sintesi praticamente scomparirebbe. Esempi sono, Ermenegildo Zegna, Adolfo Dominguez, Marithé e Francois Girbaud ... e tantissimi altri. Cambiando settore, il requisito di sintesi, che è alto in una banca commerciale, scompare in una banca centrale; legittimamente, questʼultimo potrebbe avere un logo esteso e un simbolo complesso.
Quindi, esattamente che cosa, un brand deve rispettare? Per chiudere lʼarticolo, ho detto che queste condizioni provengono da due fonti: il profilo dellʼentità e le condizioni in base alle quali emetterà i suoi messaggi visivi. Che non è poco da chiedere: ogni brand (qui “tutto” è totalmente valido) deve essere fedele allʼidentità del marchio e al modo in cui sarà trasmesso.
Cioè, il marchio non deve “disidentificare” lʼentità, non deve essere gratuita, capricciosa, artificiale, assurda; ma deve apparire come “lʼunico modo per identificare quellʼargomento”. Quel segno, che sarà sempre nato con un certo grado di casualità (la sua forma non sarà mai “scientifica”) non dovrà essere migliorabile e giudicabile. Ciò alimenterà lʼaccumulo di capitale del marchio.
E quel profilo deve essere capito, piuttosto che come “identità” come “personalità” o “carattere”. Sono le caratteristiche tipologiche e stilistiche (come nelle persone) che connotano lʼidentità. Solo sullo sfondo possono apparire riferimenti semantici, se sono necessari (in generale, non lo sono). Essere fedele allʼidentità non è sinonimo di “narrarlo”. Una di quelle credenze errate è, appunto, a priori, della narratività obbligatoria.
Le prostitute (nobile professione che meriterebbe un maggiore rispetto) sono pubblicamente identificate attraverso una serie di stili di comportamento, abbigliamento e trucco, che evitano ogni malinteso. Nessuna di loro ha un cartello che dice “Sono una prostituta” sul petto (cerco di essere chiaro). Lʼidentità è più una questione di retorica più che di semantica.
La seconda fonte di condizionamento sono le condizioni di emissione. Il marchio deve avere prestazioni funzionali eccellenti; ma questo requisito di prestazione non è identico in tutti i casi. Come il profilo, quella prestazione dipende da ogni specifica entità. Alcuni devono urlare, altri parlano a bassa voce. Alcuni devono essere in grado di essere letti ad alta velocità, altri con tutto il tempo del mondo. Alcuni devono fare colpo sulla società allʼistante, altri non importa se si ricordano o no. Alcuni devono essere inusuali, altri abbastanza convenzionali. La chiave è sapere in quale caso fa parte ogni cliente.
In breve, lʼopposto del dogma non è la piena libertà, ma il riconoscimento e il rispetto delle condizioni specifiche per ciascun caso. «Non ci sono malattie, ma malati»; e la medicina che salva alcuni può uccidere altri. Il dogmatismo è il risultato della pigrizia intellettuale che, invece di prendersi la briga di conoscere a fondo il paziente, che è unico e irripetibile e dargli un trattamento personalizzato, gli prescrive il farmaco standard ... e che passi il prossimo!
Tra i commenti ricevuti a questo articolo, uno che merita unʼattenzione particolare: è la domanda sullʼorigine di queste dodici «norme»: da dove le ho estratte? E darò una risposta, perché è un tema che fa discutere. Qualsiasi professionista esperto troverà inutile dover spiegare cose così ovvie (e questo appare in alcuni commenti dei lettori). Ma la realtà dimostra che poi così ovvie non lo sono. Queste false norme universali non sono state inventate da me per “stuzzicare” nessuno. Le ho sentite, per decenni, uscire dalla bocca di studenti, professionisti, clienti e cosa ancor più grave da insegnanti.
Dʼaltra parte, ho solo riprodotto quelle più banali: ci sono molti altri miti. E per dimostrarlo, sarà sufficiente vedere lʼesuberante quantità di brand difettosi - che sono il risultato di quelle credenze - usciti dalle mani dei designer. Questi tipi di errori, non solo li commettono le piccole agenzie di quartiere, ma anche le multinazionali supportate da aziende di design aziendale che si auto-promuovono come leader nel branding. La critica, quindi, è pienamente giustificata.
Fortunatamente, è ovvio che non tutti i grafici praticano questo tipo di pensiero elementare. Ci sono professionisti, giovani e maturi, nel cui portfolio è difficile trovare degli errori. E questo, perché dominano perfettamente la tipologica e la stilistica; e sanno come amministrarla saggiamente in ogni caso. Per questo motivo, il loro lavoro dà spesso lʼimpressione di unʼopera realizzata da diversi autori: non ci sono manierismi o formule, né tantomeno uno stile personale.
Ma il rischio delle “ricette” (per non parlare delle mode) è molto alto. Qualche anno fa un designer mi ha mostrato il suo ampio catalogo di marchi, tutti di eccellente qualità grafica. Cʼerano tutti i tipi di clienti: istituzioni pubbliche, aziende, prodotti di consumo, catene commerciali, associazioni professionali. Nonostante ciò, lʼassoluta totalità dei marchi ha risposto a un singolo modello: il tipico simbolo iconico più il logo. Mi sono congratulato con lui per la qualità e gli ho chiesto perché ha dato a tutti le identiche risposte tipologiche. Senza esitare un momento, con assoluta certezza, come qualcuno che conosce la verità, disse: “Il simbolo è indispensabile perché permette una lettura più veloce del logo”. E rimase così tranquillo, convinto che mi avesse insegnato qualcosa. Diplomaticamente, lʼho ringraziato per il suo insegnamento; ma tra me, ho pensato: “E chi ti ha insegnato che la velocità sia un requisito universale e che tutti i loghi siano lenti?”
Se un adulto recita spudoratamente unʼassurdità del genere, non devi mai contraddirlo. Io scrivo, fondamentalmente, per gli studenti. Cerco, tra le altre cose, di avvertirli dei rischi delle “ricette”. Dʼaltra parte, per quei professionisti che hanno già credenze cristallizzate che danno loro sicurezza e li salvano dallo sforzo di pensare, non ci sono consigli per aiutarli o per far aprire loro gli occhi: vedranno sempre quello che hanno deciso di vedere prima ancora di guardare.
Eccellenza Professionale
Se cerchi contenuti con questo livello di rigore, ti interesserà la nostra offerta accademica. Corsi progettati per rispondere alle reali esigenze della professione.
Visualizza Offerta AccademicaCondividi
Per favore, valorizza il lavoro editoriale utilizzando questi link invece di riprodurre il contenuto su un altro sito.

Argomenti trattati in questo articolo
Cosa ne pensi?
Il tuo punto di vista è prezioso. Condividi la tua opinione con la community nella discussione.
Esprimi subito la tua opinione!