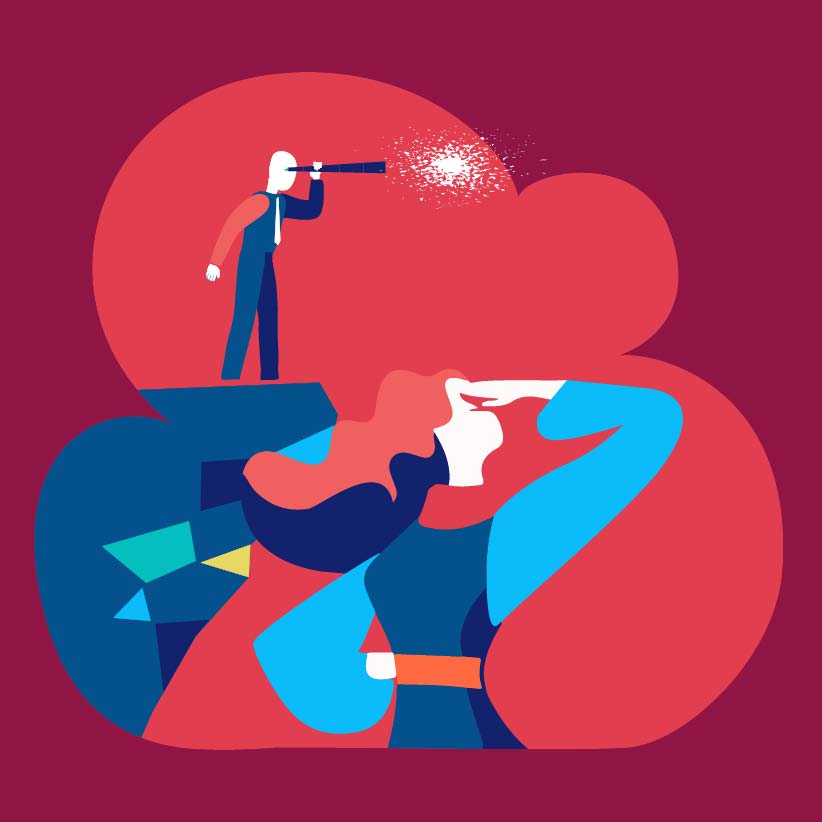In questa guida troverai:
Cos'è la comunicazione sociale e qual è la sua importanza?
La comunicazione sociale è la disciplina che studia i complessi processi di produzione, circolazione e ricezione di senso nella società. Supera la nozione semplicistica di una mera trasmissione di informazioni per analizzare come i messaggi costruiscono la realtà sociale, mediano nelle relazioni di potere e configurano la cultura. Non si tratta di un atto neutrale, poiché ogni mezzo e ogni messaggio sono carichi di intenzioni, pregiudizi e cornici interpretative.
La sua importanza è capitale per capire come si forma l'opinione pubblica, come si articolano le identità collettive e come si promuove il cambiamento o si mantiene lo status quo. Per i professionisti del design, del branding e della comunicazione, la comunicazione sociale offre l'impalcatura teorica per creare messaggi che non siano solo persuasivi, ma anche culturalmente risonanti, eticamente responsabili e strategicamente consapevoli del mezzo in cui operano, riconoscendo che questo non è mai un semplice veicolo, ma parte costitutiva del messaggio.
Quali sono le principali teorie della comunicazione sociale?
Più che un elenco di autori, è utile comprendere i paradigmi che hanno plasmato la disciplina. I primi modelli, come quello di Lasswell («chi dice cosa, in quale canale, a chi, con quale effetto»), concepivano la comunicazione come un processo lineare e unidirezionale. Questa visione fu sfidata dalla Teoria Critica della Scuola di Francoforte, che analizzò i mass media come apparati ideologici al servizio del potere, capaci di standardizzare la cultura e pacificare il pubblico.
Successivamente, le teorie si sono concentrate sugli effetti dei media. La teoria dell'Agenda-Setting postula che i media non ci dicono cosa pensare, ma su quali temi pensare, stabilendo l'agenda pubblica. In contrapposizione, approcci come la teoria degli Usi e Gratificazioni invertono la prospettiva, presentando il pubblico come agente attivo che seleziona e utilizza i media per soddisfare bisogni specifici, dall'informazione all'integrazione sociale.
Infine, l'opera di teorici come Marshall McLuhan rimane fondamentale. Il suo celebre assioma «il medium è il messaggio» ci obbliga ad analizzare come la tecnologia stessa della comunicazione —che sia la stampa, la televisione o internet— plasmi la percezione umana e la struttura sociale, indipendentemente dal contenuto che trasmette.
Qual è la differenza tra comunicazione sociale e giornalismo?
La distinzione fondamentale risiede nella portata e nello scopo. Il giornalismo è una specializzazione all'interno del vasto campo della comunicazione sociale. La sua funzione primordiale è la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni di interesse pubblico, con un impegno ideale di veridicità, verifica delle fonti e oggettività. Il suo fine ultimo è il servizio informativo alla cittadinanza.
La comunicazione sociale, invece, è la disciplina madre che ingloba il giornalismo insieme ad altre aree come le relazioni pubbliche, la comunicazione d'impresa, la pubblicità, la comunicazione politica e gli studi sui media. I suoi obiettivi sono diversi e non sempre informativi: possono essere persuasivi (pubblicità), relazionali (gestione della reputazione), organizzativi (comunicazione interna) o di intrattenimento. Mentre il giornalista si deve (in teoria) all'interesse pubblico, il comunicatore sociale può avere come obiettivo gli interessi di un'organizzazione, di un marchio o di una causa.
In che modo i social network influenzano la comunicazione sociale?
L'irruzione dei social network rappresenta un cambio di paradigma, non solo un'evoluzione tecnologica. Hanno smantellato il modello di diffusione verticale e unidirezionale (da uno a molti) proprio dei mass media, sostituendolo con una struttura reticolare e multidirezionale (da molti a molti). Ciò ha frammentato il pubblico e ha eroso l'autorità degli emittenti tradizionali.
Questa trasformazione obbliga i comunicatori ad abbandonare l'idea di un controllo totale sul messaggio. Il pubblico non è più un recettore passivo, ma una rete di «prosumer» che interpretano, rimescolano e ridistribuiscono il contenuto, diventando un attore chiave nella costruzione di significato. Questo ambiente richiede nuove logiche strategiche, come la narrazione transmediale, e una capacità di risposta agile di fronte alla viralità, che può tanto amplificare un messaggio quanto scatenare una crisi reputazionale in poche ore.
Come si elabora un piano di comunicazione sociale?
Un piano di comunicazione è uno strumento strategico, non un semplice elenco di azioni. Il suo sviluppo è un processo metodologico che inizia con una diagnosi rigorosa: un'analisi approfondita dell'ambiente, dell'organizzazione, del pubblico (stakeholder) e del problema o dell'opportunità da affrontare. Questa fase di ricerca è fondamentale affinché la strategia si basi su evidenze e non su intuizioni.
A partire dalla diagnosi, si definiscono obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e con una Scadenza), che stabiliscono cosa si vuole ottenere. La strategia è l'approccio concettuale che guiderà tutte le azioni, definendo il messaggio chiave, il tono di voce e gli argomenti centrali. È il «come» si raggiungeranno gli obiettivi, l'idea guida che dà coerenza al piano.
Infine, si scompongono le tattiche (azioni concrete come campagne di contenuti, eventi o gestione dei media) e si selezionano i canali più adatti per ogni pubblico. Una fase critica, e spesso sottovalutata, è la valutazione: stabilire indicatori chiave di prestazione (KPI) che permettano di misurare non solo la diffusione dei messaggi, ma il loro impatto reale sulle percezioni, attitudini o comportamenti del pubblico.
La responsabilità sociale nella comunicazione è un impegno etico che trascende il mero rispetto della normativa legale. Implica una coscienza critica sul potere che i messaggi hanno di configurare la realtà, influenzare gli atteggiamenti e perpetuare o sfidare gli stereotipi. Non si riferisce unicamente a «cosa» si comunica, ma al «come» e alle conseguenze prevedibili di tale atto comunicativo.
In pratica, si traduce in un impegno per la veridicità, la trasparenza sulle intenzioni (specialmente in contesti persuasivi come la pubblicità) e la promozione attiva della diversità e dell'inclusione. Significa progettare comunicazioni accessibili a persone con diverse abilità, evitare l'appropriazione culturale indebita e non strumentalizzare le comunità vulnerabili. In sostanza, è assumere che ogni atto di comunicazione ha un impatto pubblico e che il professionista è corresponsabile dei suoi effetti sulla società.